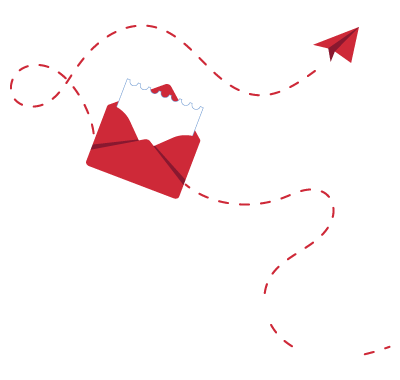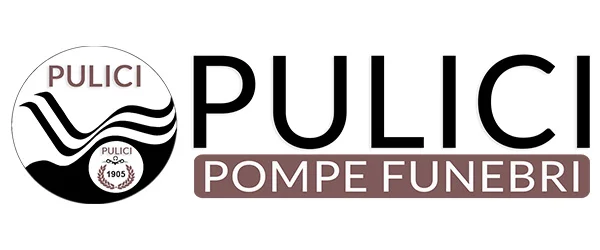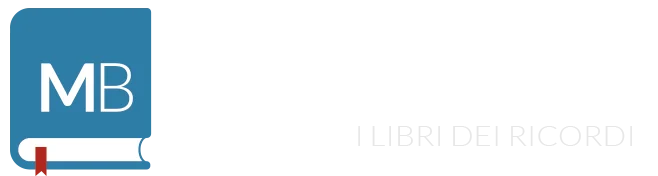17 luglio 1959. Muore Billie Holiday, la voce spezzata che canta l’America.

Billie Holiday nasce il 7 aprile 1915 a Filadelfia, ma cresce a Baltimora, in un’America segnata dalla segregazione razziale e dalle disuguaglianze.
La sua voce, densa e ferita, si fa spazio nei locali di Harlem negli anni Trenta, quando comincia a cantare nei club e viene notata per il suo stile interpretativo inconfondibile.
All’inizio la chiamano Lady Day, un soprannome che le viene dato dal sassofonista Lester Young, con cui instaura un sodalizio umano e musicale.
La sua carriera decolla con What a Little Moonlight Can Do, ma è Strange Fruit, nel 1939, a segnare una frattura definitiva tra arte e denuncia.
In quella canzone, Holiday canta senza filtri la brutalità dei linciaggi nel Sud degli Stati Uniti, sfidando apertamente le convenzioni e i poteri del tempo.
L’arte come sussurro di verità
Billie Holiday non ha una tecnica vocale classica, ma piega ogni nota al sentimento.
Le sue interpretazioni sembrano raccontare una storia più grande di lei: quella di un Paese che fatica a guardarsi allo specchio.
I brani come God Bless the Child, Gloomy Sunday e Lover Man mostrano una profondità emotiva che trascende il jazz.
Nonostante il successo, la sua vita personale resta segnata da dipendenze, relazioni violente e persecuzioni.
L’FBI la prende di mira per l’uso di droghe, arrivando persino a impedirle di esibirsi nei locali dove si servono alcolici, distruggendo economicamente la sua carriera.
Ma Billie resiste, continuando a cantare, anche quando la voce si spezza.
L’ultimo applauso a Lady Day
Il 17 luglio 1959, Billie Holiday muore a 44 anni in un letto d’ospedale di New York.
È ricoverata con la polizia alla porta e pochi dollari sul comodino, eppure, al suo funerale nella chiesa di St. Paul the Apostle, arrivano oltre tremila persone.
Tra loro ci sono musicisti, attivisti, e ascoltatori comuni che hanno trovato nelle sue canzoni una forma di verità e conforto.